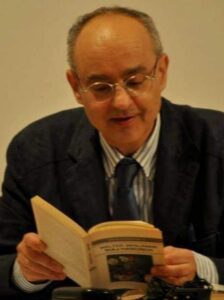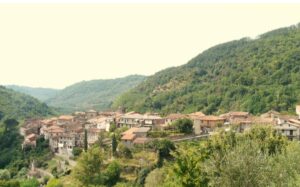L’involuzione della cultura di massa
di Patrizio Paolinelli
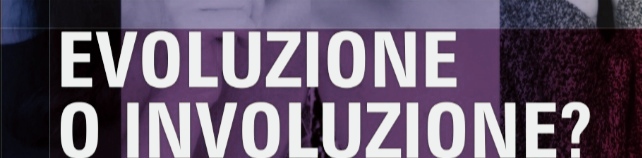
Correvano gli anni ’60 e Edgar Morin pubblicò un libro destinato a diventare un classico della sociologia: L’esprit du temps (trad. it. L’industria culturale, il Mulino, 1963). Nelle prime pagine del volume Morin definì la cultura di massa in questi termini: “essa costituisce un corpo di simboli, di miti e immagini concernenti la vita pratica e la vita immaginaria, un sistema di proiezioni e di identificazioni specifiche, e si aggiunge alla cultura nazionale, alla cultura umanistica, entrando in concorrenza con loro”.
A partire dal secondo dopoguerra la cultura di massa ha conquistato spazi sempre più larghi generando nuovi saperi, nuovi gusti estetici, nuovi stili narrativi, nuovi modelli di rappresentazione del Sé e realizzando prodotti di qualità in numerosi campi: musica, cinema, televisione, editoria. Novità, qualità, sperimentazioni pop, reciproche contaminazioni con l’arte, il teatro, la moda hanno sostenuto la volontà di evasione dal grigiore degli anni ’50 e più in generale l’idea di democratizzare la cultura. Nel giro di pochi decenni la cultura di massa ha vinto la sfida lanciata alla cultura classica e a quella elitaria accompagnandosi per un momento persino con la contestazione giovanile. Negli anni ’70 è diventata egemone in Occidente e ha iniziato la sua espansione planetaria accelerandola al massimo dopo la fine della guerra fredda. Ma tra gli anni ’80 e gli anni ’90 una volta consolidata la propria posizione nell’immaginario collettivo la qualità spettacolare dei prodotti della cultura di massa ha fagocitato quella contenutistica e l’iniziale spinta democratica si è spenta a favore della ricerca del profitto.
Mentre divorava se stessa, la cultura di massa si è perfettamente saldata con la cultura del consumo e la sua penetrazione nella società è cresciuta in estensione e specializzazione. Basti pensare al passaggio dalla paleotelevisione alla neotelevisione o alla mutazione della pubblicità da veicolo meramente promozionale a filosofia di vita. Ma lo sviluppo non si è fermato agli aspetti tecnologici o a quelli propri del settore come potrebbe essere per l’industria automobilistica. Col passaggio al post-fordismo la cultura di massa si è integrata con una lunga filiera di attività del terziario in virtù di due processi principali: 1) pratiche universali quali la comunicazione, il gioco, la seduzione, l’immaginazio¬ne, il gusto, il piacere e la cura del corpo sono diventate oggetti dell’economia politica; 2) per essere appetibile ogni merce deve apparire il più possibile come un segno distintivo, da qui la proliferazione dei marchi, l’onnipresenza del design e l’estetizzazione della vita quotidiana. Data la matrice statunitense che la caratterizza, la cultura di massa adegua la soggettività ai valori dell’utilitarismo, dell’individualismo e del consumismo. La conseguenza è un’etica della vita come gara. Etica sostenuta dalla cultura di massa tanto che oggi quasi in ogni occasione d’incontro dentro e fuori lo schermo è condizionata dalla logica della performance: una corsa senza fine per essere più prestanti, più furbi, più ricchi, più giovani, più belli, più atletici, più sexy e così via. Per giustificare questo tipo di soggettività alcuni sociologi sostengono che sono i destinatari a utilizzare i mass-media o i clienti a manipolare la moda tramite micropratiche di fruizione personalizzata dei prodotti e di ibridazione di tali prodotti con le subculture urbane. A sentir loro si tratterebbe di mediazioni che dovrebbero de-monopolizzare le gerarchie simboliche lasciando così emergere una relazione paritaria tra l’industria culturale e i suoi fruitori. In realtà il rapporto di potere tra chi produce l’immaginario collettivo e la massa sterminata di coloro che lo traducono in comportamenti reali è completamente sbilanciato a favore dei produttori. Tale asimmetria permette alla cultura di massa di esercitare un controllo di tipo politico sulla vita degli individui governandoli fin nei loro minimi gesti. Osservata sul piano regolativo la cultura di massa è soprattutto un avanzato, flessibile e spesso occulto vettore di un ethos che induce il grande pubblico al consumo di ogni cosa: dall’abbigliamento ai telegiornali, dai partner sessuali ai telefoni cellulari, dai prodotti musicali ai generi letterari, dal tipo di fumetto al modello di pettinatura, dalle mete turistiche ai prodotti cine-televisivi e così via.
Tutta la variabilità dei comportamenti collettivi generati dalla cultura di massa ha finito per mantenere in piedi gli assetti di dominio presenti nella nostra società. Il dirompente slogan Sex, drugs and rocknroll non ha minimamente arrestato la corsa verso una società sempre più programmata, sempre più diseguale. Anzi l’ha rafforzata tra gli applausi dei meno abbienti. Da tempo il rock è morto, poi è stato il punk a lasciarci e uno dopo l’altro se ne sono andati generi e sottogeneri musicali che però hanno dato lavoro a innumerevoli band e soprattutto hanno intrattenuto il pubblico in recinti ben circoscritti dove sfogare aggressività, frustrazioni, pulsioni sessuali o dove più semplicemente ammazzare il tempo. Intanto, nel giro di poche generazioni, il mondo occidentale si sta progressivamente feudalizzando. Addirittura Barak Obama nel suo discorso sullo stato Dell’Unione si era lamentato del fatto che negli USA la mobilità sociale ha il fiato corto nonostante la nazione sia risorta dalla recessione.
E il sesso? E sempre più sfruttato dalla cultura di massa tanto da farne una vera e propria ossessione collettiva. La TV commerciale ha trasformato gran parte degli italiani in voyeuristi mentre star globali della pop music fanno a gara tra chi si esibisce in performance sempre più spinte. L’escalation della provocazione che va da Madonna a Lady Gaga fino a Miley Cyrus concede maggiore spazio ai richiami dell’eros che alla musica, mentre al di fuori dello schermo le persone sono più sole, diffidenti e instabili. In quanto alla libertà sessuale, se davvero fosse generalizzata, non si assisterebbe al dilagare della prostituzione e della pornografia. Non ce ne sarebbe bisogno. Ma il bisogno c’è e la cultura di massa gestisce la sessualità orientandone pratiche e saperi. L’oggetto privilegiato resta il corpo delle donne. Un corpo estetizzato, erotizzato che serve non solo a vendere merci ma che è stato trasformato in un’arma utilizzata dal potere politico. E anche in nome della libertà delle donne che negli anni scorsi L’occidente ha bombardato questo o quel paese islamico. I media si accodano alla propaganda e quasi non c’è testata giornalistica che non dia notizie sull’oppressione delle donne nel mondo arabo senza interrogarsi seriamente sulla complessità di quel mondo, sulla sua cultura, i suoi valori, la sua storia. Il modello che la cultura di massa impone è il corpo glamour: quello delle starlette hollywoodiane e delle top model. Possibile che non esistano altre forme di libertà dal patriarcato e altre modalità di espressione del desiderio? Per la cultura di massa no. Pretende il monopolio e rivela così il suo volto autoritario.
Il controllo sul corpo non è separato dal controllo della coscienza. Attraverso riti, media e mode la cultura di massa ha annesso la parte socializzata del Sé (il Me) riducendo ai minimi termini la parte individuale (l’Io). Un paradosso per le società liberali che sostengono di valorizzare al massimo l’individuo. Ma al di là della retorica la cultura di massa è un apparato di potere che influenza profondamente la vita pubblica e privata delle persone e in virtù di tale influenza ne governa la soggettività. Sul piano individuale il risultato è un anticonformismo telecomandato. Sul piano sociale è una diffusa forma di alienazione. Come ricostruire un rapporto più equilibrato tra l’Io e il Me? Un utile esercizio può essere quello di porsi delle domande sul proprio immaginario. Eccone alcune. Perché quella canzone che ho canticchiato per settimane a un certo punto non mi piace più? Perché non sopporto il silenzio? Da cosa nasce il desiderio di non perdere una puntata di quella fiction? Chi mi ha inculcato la paura di invecchiare? Cosa mi spinge a desiderare così tanto quel paio di stivali? Come mai mi spaventa un libro che supera le cento pagine? Perché sento di non avere mai tempo? Da dove provengono i sogni a occhi aperti che faccio di tanto in tanto? L’attrazione fisica verso quella persona nasce dal mio mondo interiore o dal mondo delle immagini che attraverso e che mi attraversa ogni giorno?
dott. Patrizio Paolinelli, sociologo e giornalista